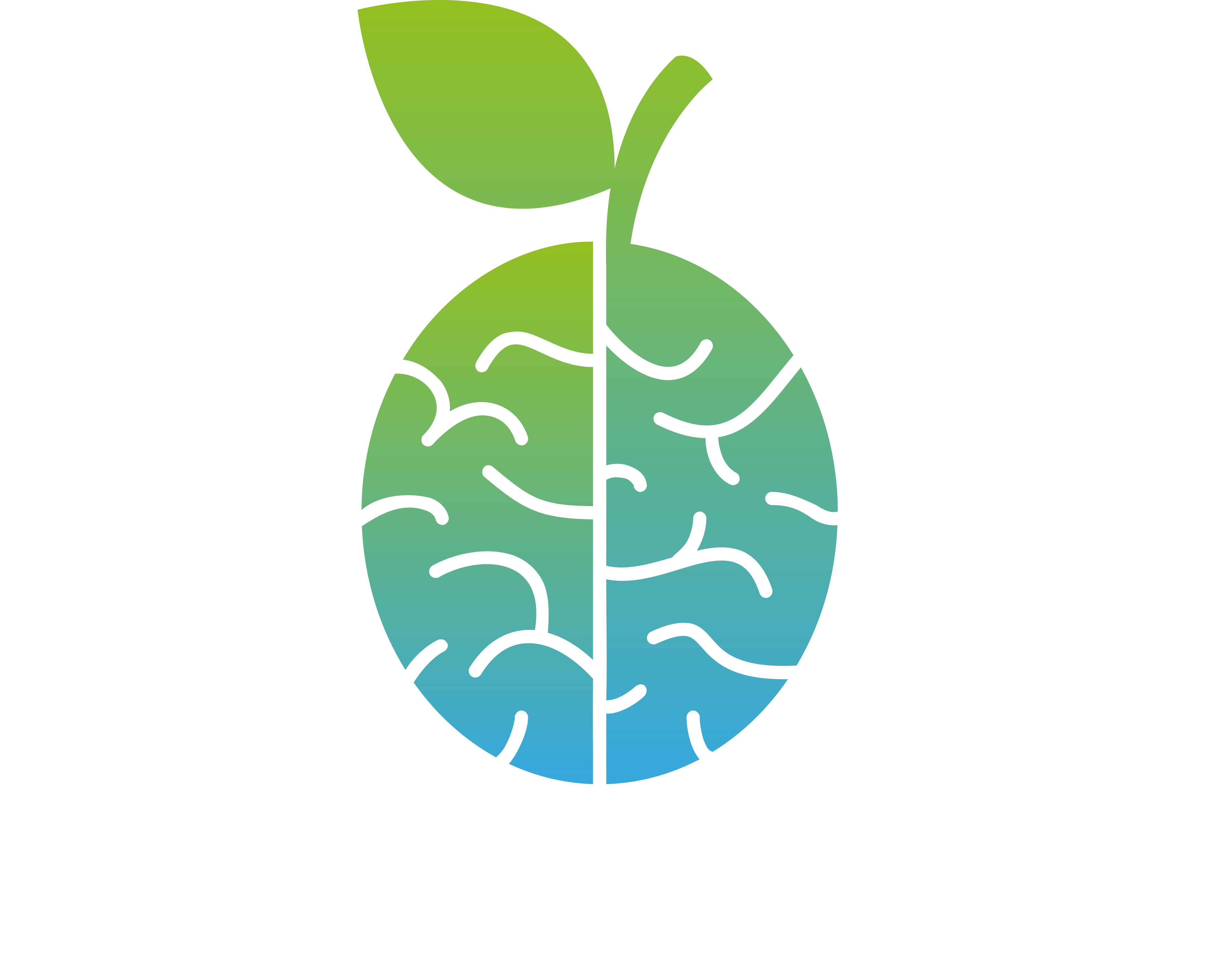La prima interazione che ho avuto con il vero Parmigiano Reggiano è stata dopo un funerale. All’epoca stavo con un ragazzo italiano, che raggiunsi dopo una tragedia in famiglia per stargli vicino. In provincia di Reggio Emilia. Considerate che abitavo a New York e che all’epoca non avevo mai nemmeno sentito nominare l’Emilia-Romagna. Si trattava del mio primo volo da sola ed ero terribilmente nervosa. Il volo durò sette ore e mezza da New York City a Milano, poi dopo circa due ore di auto mi raggiunse un odore pungente, quasi soffocante, di letame. “Ma dove mi ha portato?” mi chiedevo: ecco, ero arrivata nel reggiano.
Esausta, fissavo a bocca aperta la nebbia che accarezzava l’erba. Ricordo che i colori erano così vividi, come se fosse ancora estate e non fine novembre. La foschia indugiava intorno alle finestre e alle porte della gelida villa dove il mio ragazzo abitava con la famiglia, mentre iniziavamo a preparare la cena. Finalmente trovai un modo per sentirmi utile tra gli estranei, dato che ho sempre considerato la cucina una lingua universale e la mia conoscenza dell’italiano si limitava a cinque parole. Era facile intuire però che sua mamma, la neo-vedova, non si fidasse molto di me, un’americana… ad eccezione del tagliare il pane e mettere in tavola il Parmigiano. Mi passò con esitazione una “punta” così grande (all’epoca non conoscevo questo nome, per me era solo un “blocco” di formaggio), che mi fece pensare che sarebbe servito un vassoio da portata. Cercai un piatto in ceramica, ma lo sguardo della madre evidenziò il mio errore, uno sguardo così tagliente che avrebbe potuto sezionare il formaggio stesso. Il mio ragazzo mi venne in soccorso con un tagliere di legno e un coltellino. Lessi l’iscrizione sul coltellino, che rifletteva la luce soffusa del soggiorno: Parmigiano Reggiano. La “punta” era messa accanto alla pentola fumante coi cappelletti, con quel coltello adagiato al suo fianco. Mi fissai sul formaggio, che mi appariva quasi come una statua posata sul tavolo. Aspettavo con trepidazione di vedere come gli altri lo avrebbero tagliato. Alcuni usavano il coltello per raschiare un po’ di formaggio nel brodo dei cappelletti, ma la cosa non sembrava avere molto senso per me. Poi, lo vidi quasi in slow-motion: la punta del coltellino entrava nel lato del blocco di formaggio e il polso si apriva per far cadere, con grazia, pezzi di Parmigiano gloriosamente grandi. Una “punta” che oggi, quattro anni dopo, considererei poco stagionata per i miei gusti. I pezzi vennero lasciati scivolare nel brodo caldo, per sciogliersi appena. Emisi un sussulto che ruppe il silenzio, nella cena meno confortevole che io abbia mai avuto.

Cominciai a fare tante domande: “Come fai a sapere se è buono?” e “dove viene prodotto?”. Hanno condiviso con me quante più conoscenze possibili sul loro formaggio, il che, considerando che sono nati e cresciuti nella zona, risultò davvero molto poco. Non riuscivo a capacitarmi del fatto che su di una cosa così buona, che faceva parte della loro vita quotidiana, non ne sapessero quasi nulla.
È stato durante questo periodo che ho iniziato a fare alcuni cambiamenti nel mio stile di vita e nella mia dieta, iniziando a esplorare cibi differenti. Questa prima esperienza a Reggio mi colpì profondamente. A partire dal primo assaggio dei cappelletti, dell’erbazzone e, soprattutto, del Parmigiano Reggiano, divenni ossessionata dal confronto con la qualità del cibo disponibile in America. Perché noi americani dobbiamo faticare così tanto per riuscire a mangiare bene, e ciononostante il nostro cibo non è ancora abbastanza buono? Perché ci sono così tanti ingredienti, conservanti e sostanze chimiche nel nostro cibo? Al ritorno in America passavo ore, al supermercato, leggendo la miriade di ingredienti sui prodotti che mi avevano assicurato mi avrebbero fatto bene: yogurt, hamburger vegetariani, pane tostato integrale, ecc. Quello che scoprii era un elenco infinito di ingredienti, che non riuscivo nemmeno a pronunciare. Ritornai in Italia pochi mesi dopo e feci la stessa cosa al supermercato italiano. Lessi le etichette degli stessi prodotti, pure delle stesse marche, i quali in America avevano stabilizzanti e conservanti che in Italia non si sognavano nemmeno lontanamente di includere. Al supermercato mi capitò di fissarmi sul frigorifero dove c’era il Parmigiano Reggiano, circondato da una luce che lo rendeva così bello e raggiante. Esitai un attimo prima di leggere l’etichetta: non volevo che la bella esperienza che avevo avuto con questo formaggio venisse spazzata via, per colpa di ingredienti imposti dal mercato consumistico. “Latte, sale, caglio” recitava l’etichetta. Tutto qui…? Sì, tutto qui!

Anche l’erbazzone acquistato al supermercato non aveva conservanti e conteneva meno ingredienti, ad esempio, delle patatine reperibili negli Stati Uniti. Da quel momento in poi si può dire che mi sono sentita a mio agio qui, superando la mia ossessione. La mia missione personale è diventata quella di correggere la disinformazione che esiste in America riguardo al cibo. Praticamente, iniziai con una sorta di terza guerra mondiale dopo la cena di Natale di quell’anno, insistendo affinché la mia famiglia smettesse di chiamare il Parmigiano Reggiano “Parmesan”. È una cosa che ancora oggi mi fa ribollire il sangue.
Il giorno del mio trasferimento definivo in Italia, mi fu chiesto di cantare al matrimonio di un amico. Dopo il sofferto commiato dalla mia famiglia e dopo non aver chiuso occhio sul volo, ero troppo esausta, emotivamente e fisicamente, per voler conoscere la band che mi avrebbe accompagnato, quindi mi limitai a cantare e basta. Dopo aver finito di suonare, mi congratulai con tutti e andai a prendere un piatto di antipasti. Mentre stavo rompendo dei grossi pezzi dalla forma del Parmigiano Reggiano, il chitarrista del gruppo mi si avvicinò. Il mio italiano era ancora molto limitato, ma avevo studiato un po’ prima del trasloco, così potei perlomeno capire che mi stava parlando del formaggio, che a dire la verità era l’unica cosa che realmente mi interessava in quel momento. “Lavoro come battitore del Parmigiano Reggiano” disse, così, casualmente… Mi sembrò che, in quel preciso momento, tutto il matrimonio si bloccasse e che lui mi avesse quasi sussurrato all’orecchio qualcosa di scandaloso: “Ti posso portare a fare una visita in caseificio se vuoi”. Sollevai lentamente i miei occhi assonnati verso di lui con un brivido di eccitazione. Era quasi come se mi avesse fatto “la proposta”. Non avrei potuto sognare nulla di più spettacolare.

Era il 31 luglio 2018. Arrivai al caseificio di Villa Curta alle 7.30 spaccate. Intorno a me c’erano delle mucche e dei cavalli al pascolo e l’odore dolce dell’aria del mattino d’estate, questa volta solo con una piccola traccia di letame. Il “battitore” mi aspettava all’ingresso del caseificio. Come aprì la porta un fastidioso rumore di macchinari mi si rovesciò addosso e l’unica cosa che potevo vedere erano grosse cisterne metalliche con su scritto “latte”. Lui si avvicinò e mi disse che il latte veniva lasciato a riposo tutta la notte per far affiorare la parte grassa, la crema; proseguì spiegandomi cose che non avevo mai immaginato potessero stare a monte di ciò che mangiavo: di cosa si alimentano le vacche, chi porta il latte in caseificio, quante volte al giorno, ecc. Mi sorprese sapere che le vacche mangiano foraggio che proviene dall’area e che, come mi venne spiegato, tra le zone della provincia il fieno è diverso e questo cambia il gusto del formaggio.
Il “battitore” aprì un’altra porta svelando il locale con le caldaie, dove i casari erano indaffarati al lavoro: sembrava quasi un balletto. Guardai con stupore un casaro che rompevano la cagliata un lungo strumento dall’aspetto medievale, che mi dissero si chiamava “spino”. La sua mano poi si immergeva a intervalli in un’altra caldaia per controllare la formazione e la consistenza della cagliata. Da un momento all’altro mi sono trovata con in mano un pezzo di formaggio appena estratto da una vasca e una tazza di siero fermentato nell’altra. È stata un’esperienza rara e non avrei mai immaginato in vita mia di assaggiare Parmigiano Reggiano “stagionato” solo 30 secondi (quindi, non ufficialmente Parmigiano Reggiano). Alla prima sorsata di siero dovetti trattenere l’impeto del vomito, non solo a causa della sua acidità ma anche dell’odore. Avevo fatto formaggi di capra a casa, quindi il gusto del siero non mi era nuovo, ma questo risultò molto acidulo e pungente, in quanto era fermentato. Mi sentii in dovere di trangugiare tutta la tazza, per non offendere i casari, e così feci con un grande sforzo. Mi venne da sorridere quando mi accorsi che nessuno degli altri si era sentito in dovere di farlo e tutti erano perfettamente a proprio agio nel lasciarla quasi piena. In seguito il casaro si avvicinò alla caldaia con quella che sembrava la lunga pala di legno per girare la pizza nel forno. L’immerse fino al fondo della caldaia, cominciando a far leva sul bordo con tutta la sua forza, riuscendo così a far affiorare una massa tondeggiante di formaggio, grande due volte me. La avvolse quindi in una pezza di tessuto e l’appese ad un traverso in legno, per scolare il siero, che verrà poi usato per fare la ricotta (perché in Italia non si spreca niente). Davanti ai miei occhi ho visto la “nascita” di una forma di Parmigiano, fasciato nel suo piccolo panno come un bambino. Il mio amico, a cui ancora oggi mi riferisco come Parmigiano Man, mi ha mostrato la fascia in plastica che imprime il nome Parmigiano Reggiano sul lato delle forme. Scorrevo con le dita sui suoi dettagli in rilievo, così impressionata dalle cose che devono accadere per creare una forma di questo formaggio: una prodotto che invece avevo sempre dato troppo per scontato. Non potevo credere che tutto ciò che vedevo, fosse il prodotto di tradizioni nate più di mille anni fa nella zona. Potevo toccare, assaggiare, annusare, sentire una parte della storia di questo pezzo d’Emilia: una sensazione che non potrei mai avere negli Stati Uniti, anche a causa della loro storia recente.

Il mio tempo trascorso a Reggio è stato pieno di avventure. Ho camminato per giorni in Appennino, assaggiando tutto l’erbazzone che ogni forno della città può offrire. Ho cominciato a frequentare i caseifici i tutte le occasioni che mi si presentavano. Mi si illuminavano gli occhi alla possibilità di raccontare ai miei compatrioti in famiglia, la vita e la coinvolgente storia del Parmigiano. Ora sono diventata una tale snob di questo formaggio, che ho addirittura preferenze relative alle aree di produzione o alle stagionature. Ma ancora, dopo due anni e mezzo che vivo qui, i reggiani continuano sempre a chiedermi straniti “… ma come mai da New York a Reggio Emilia?” E io riesco a rispondere semplicemente, con l’erbazzone artigianale in una mano e un calice di fresco lambrusco nell’altra, “… da dove devo iniziare?”

ORIGINAL ENGLISH VERSION